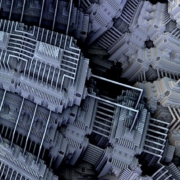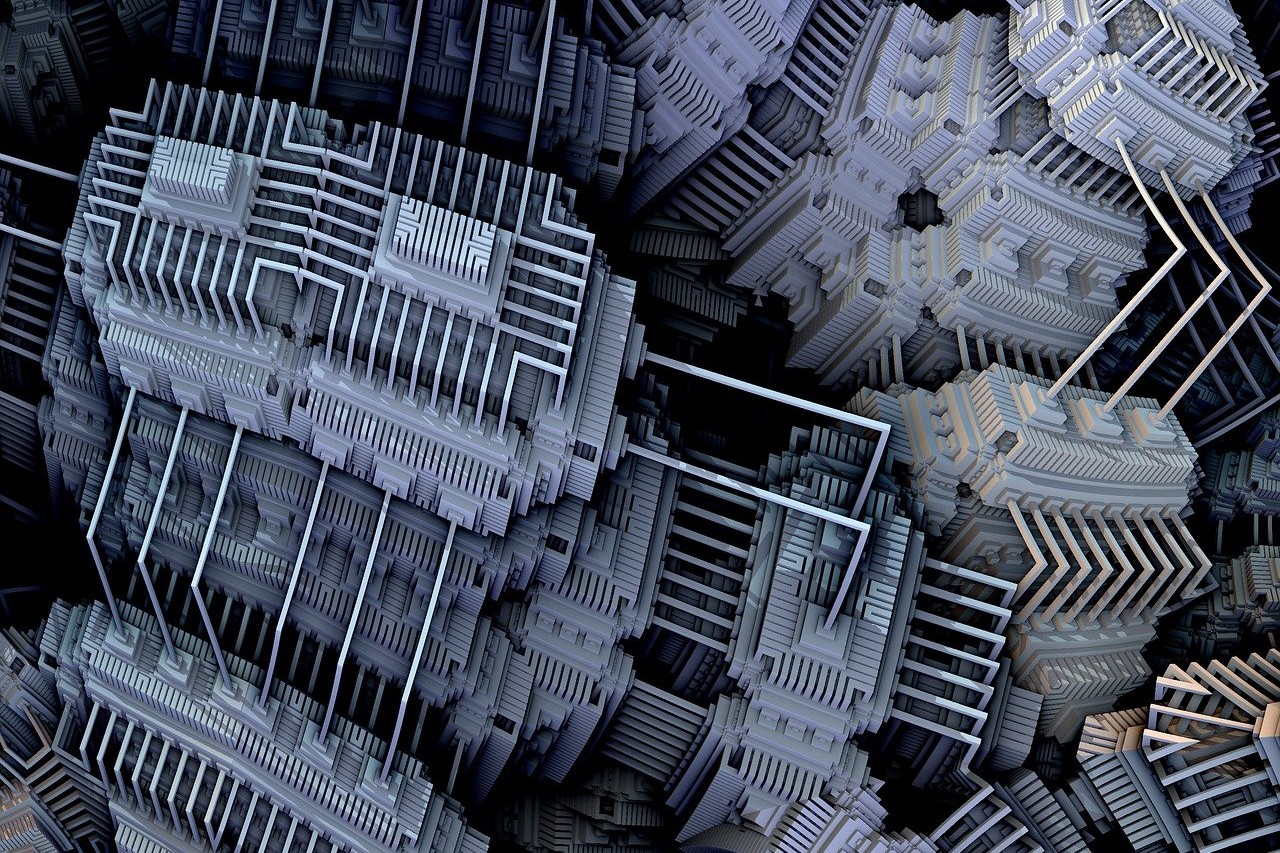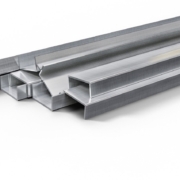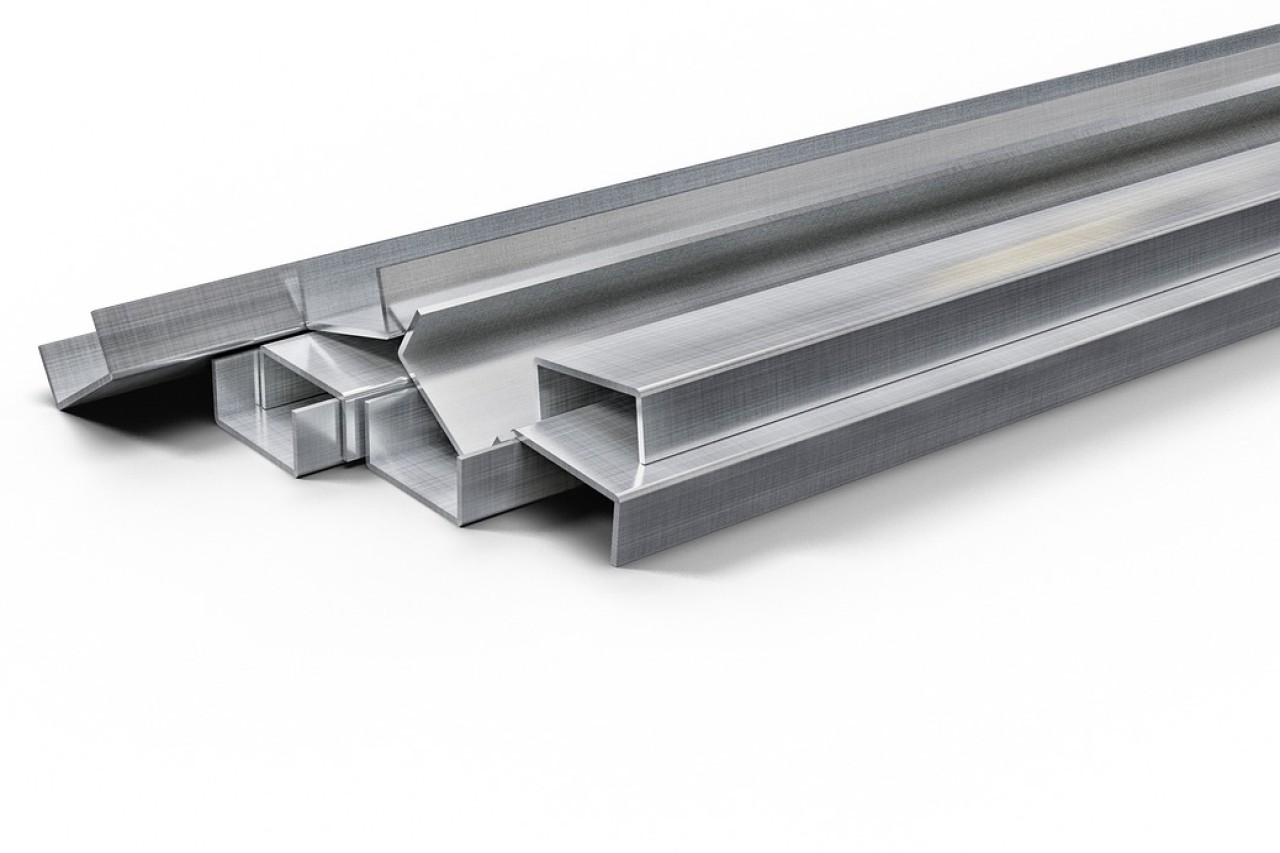Negoziare? Si, no, forse, magari…
Nel mirino USA non solo le merci ma anche le regole

Fiumi di parole, ipotesi, dibattiti, proposte di vario genere e via discorrendo. La “nuova” via delle relazioni commerciali internazionali inaugurata dall’attuale amministrazione americana ha scosso tutti e disorientato governi, aziende, commentatori…
L’uso del virgolettato per l’aggettivo “nuova” non è però casuale, perché alcuni elementi sembrano sfuggire ai più, benché siano o dovrebbero essere noti.
Intanto la “tregua” concessa dal presidente americano, che ha sospeso per 90 giorni parte dell’applicazione dei dazi (il 10% di base è rimasto e la Cina è stata esclusa dall’eccezione), dovrebbe permettere di riordinare le idee e/o di intavolare discussioni e negoziati. In questo senso il Consiglio federale si è mosso molto bene, senza panico e cercando rapidamente il contatto diretto con Washington.
È indubbio e appare chiaro come Donald Trump non creda nel multilateralismo e prediliga i negoziati bilaterali con i singoli paesi. È parimenti evidente come utilizzi in maniera più che disinvolta misure anche draconiane, per obbligare la controparte a mettersi al tavolo delle trattative. Modo di fare spettacolare e senz’altro di rottura con il recente passato, ma sarebbe sbagliato pensare che le trattative e le relazioni commerciali siano sempre state all’insegna dell’eleganza oxfordiana.
I rapporti di forza non sono nuovi, forse ci si era illusi che tutti giocassero sempre in maniera corretta e che dietro l’apparente armonia dei partenariati internazionali non ci fossero prove di forza, ripicche e attriti. Basti pensare, rimanendo nel “piccolo” contesto elvetico, che per concludere l’Accordo di libero scambio con l’India ci sono voluti 15 anni…
I precedenti ci sono…
È chiaro che i metodi ruvidi di Donald Trump possono non piacere. Ma sono veramente così “nuovi”? Nei toni espressi pubblicamente probabilmente sì, ma la politica economica americana è sempre stata caratterizzata dall’”America First”, scelta di per sé più che legittima.
E anche i dazi hanno una lunga tradizione. Si potrebbero scomodare esempi dall’antichità o il celebre caso dello Smoot-Hawley Tariff Act del 1930, quando il Congresso americano, in piena crisi economica, aumentò drasticamente le tariffe su moltissimi prodotti di importazione per difendere l’agricoltura e l’industria americana, con effetti devastanti anche a livello mondiale.
Ma, per restare in tempi più recenti, l’Organo per la risoluzione dei conflitti (Dispute Settlement Body, DCS) dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC, purtroppo ormai clamorosamente assente dalla scena pubblica da anni…) è stato confrontato, dall’anno della creazione dell’istituzione nel 1995, a 283 casi coinvolgenti gli Stati Uniti. In 124 casi gli Stati Uniti hanno intentato procedure contro altri paesi, in 159 sono finiti sul banco degli “accusati”. Molti di questi casi sono legati a misure tariffali, come l’imposizione di dazi su importazioni di acciaio e alluminio, ormai un grande classico che ritorna continuamente, e su altri prodotti, soprattutto cinesi.
Giocando con barriere non tariffali come il divieto d’importazione negli USA di gamberetti pescati senza dispositivi di protezione per le tartarughe, oppure con sussidi (illegali) al cotone indigeno o dazi sull’olio d’oliva spagnolo, gli Stati Uniti hanno sempre cercato di proteggere la propria industria. Come fanno un po’ tutti, del resto, anche se magari in una modalità diversa e meno spettacolare. Anche l’Unione Europea qualche mese fa ha messo i dazi sulle auto elettriche cinesi (cosa che la Svizzera saggiamente ha deciso di non fare) e la Cina ha risposto con dazi sul cognac, possibili dazi sulle auto europee di grossa cilindrata e indagini su prodotti alimentari europei. Senza dimenticare che la Cina, in virtù della sua posizione di forza sulle terre rare, gestisce a piacimento controlli sulle esportazioni verso il mondo occidentale di materie fondamentali ad esempio per la produzione di microchip essenziali per gli apparecchi elettronici di ogni genere.
Questo per dire che la tentazione protezionistica è sempre stata un’arma utilizzata dagli Stati Uniti, ma non solo, sebbene in questo momento storico i metodi siano decisamente più ruvidi e non si proceda in modo mirato, ma sparando a zero contro tutto e tutti, sulla base di un metodo di calcolo decisamente fantasioso per non dire assurdo. In nome appunto del bilateralismo che dovrebbe sostituire il multilateralismo.
Che poi la strategia sia sensata e che abbia possibilità di successo è tutto da dimostrare e chiaramente non è condivisibile per chi, come la Svizzera, sostiene fermamente il libero scambio, ma questa è un’altra discussione. Intanto però l’obiettivo di forzare gli altri paesi a negoziare è stato già almeno in parte raggiunto e addirittura tutti esultano perché per il momento si deve pagare “solo “il 10% di dazi, in attea di evoluzioni. Un vero trionfo…
Cosa negoziare?
Va detto che questa lunga tradizione di dazi americani non ha impedito all’export svizzero e a quello ticinese, in particolare, di crescere in questi anni. Merito anche di molti prodotti di alta qualità, non facilmente sostituibili e che quindi possono in una certa misura reggere all’impatto di una maggiorazione del prezzo, oppure di un’accorta politica aziendale di produzione negli Stati Uniti pur mantenendo salda la posizione in Svizzera. Vero è che al momento la posta è stata chiaramente alzata da parte americana, con una distribuzione di dazi su quasi tutti i prodotti e in proporzioni che non hanno senso.
Un conto è reagire a una misura che tocca un determinato bene, un altro conto è doversi mettere al tavolo a negoziare misure generali che colpiscono gli ambiti più disparati.
Tuttavia, lo stesso Presidente Donald Trump ha sottolineato esplicitamente che si aspetta l’avvio di negoziati, anche con la Svizzera, come del resto confermato nella lunga telefonata con la Presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter qualche giorno fa.
Ma cosa significa? Purtroppo, l’attenzione generale si è focalizzata sulle questioni puramente tariffali e la Svizzera, che ha abolito tutti i dazi industriali sulle importazioni mantenendo solo quelli sui prodotti agricoli a tutela degli interessi del settore, è rimasta inizialmente spiazzata.
Su cosa si potrebbe negoziare? Fortunatamente sembrano scartate le fantasiose ipotesi di rappresaglia, come la sospensione dell’acquisto degli aerei da combattimento F-35, che toccherebbe pesantemente anche la nostra industria. Anche perché, come ci si è resi conto ad esempio in Francia, boicottando i prodotti americani e nello specifico la Coca Cola, si metterebbero in ginocchio molte delle aziende indigene che si occupano della produzione e della distribuzione della bevanda nel paese.
Situazione non facile e la via negoziale subito ipotizzata dal Consiglio federale sembra effettivamente l’unica praticabile, anche perché, date le nostre dimensioni nazionali, non siamo certamente nella condizione di adottare misure di rappresaglia. Purtroppo, al momento, gli argomenti razionali sono importanti ma impressionano solo fino a un certo punto.
Sottolineare che garantiamo negli Stati Uniti quasi mezzo milione di posti di lavoro qualificati, che siamo il sesto partner in quanto a investimenti diretti, ecc. al momento sembra non bastare, anche se è importante.
Probabilmente maggiore effetto sull’attuale amministrazione americana ce l’hanno annunci come quello di Novartis di investire negli Stati Uniti 23 miliardi di dollari nei prossimi 5 anni per ricerca e sviluppo…
Strano che pochi o nessuno abbiano però finora rilevato alcune piste indicate dagli Stati Uniti la scorsa settimana, ossia l’ambito di vere o presunte barriere non tariffali che infastidiscono lo Zio Sam. Il rapporto stilato ogni anno dall’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR) sugli ostacoli al commercio che i prodotti e i servizi americani incontrano all’estero, nell’edizione 2025 ha menzionato la Svizzera tra i Paesi che pongono alcune barriere problematiche secondo Washington.
Sebbene il nostro Paese goda di ottime relazioni economiche con gli Stati Uniti, il rapporto segnala varie aree critiche che andrebbero approfondite, oltre a quella ben nota dei dazi imposti dalla Svizzera sui prodotti agricoli importati. Si tratta fondamentalmente di barriere non tariffali che concernono:
- Le misure sanitarie e fitosanitarie, ritenute troppo restrittive e poco scientifiche e che limiterebbero l’accesso sul mercato di prodotti agricoli americani. Un chiaro riferimento è fatto anche alle norme svizzere che limitano fortemente la biotecnologia e quindi gli organismi geneticamente modificati.
- Proprietà intellettuale: progressi ritenuti insufficienti
Nel campo della proprietà intellettuale, il giudizio americano è in chiaroscuro. La Svizzera è stata rimossa nel 2023 dalla “Watch List” del rapporto Special 301, grazie ai miglioramenti nella tutela dei diritti. Tuttavia, gli Stati Uniti criticano l’applicazione della legislazione elvetica sul diritto d’autore e in particolare eccezioni che permetterebbero abusi importanti. - Barriere nei servizi
Nell’ambito dei servizi, gli Stati Uniti criticano in particolare la cosiddetta “Lex Netflix” che obbliga i colossi americani dell’online a versare il 4% degli introiti per sostenere produzioni svizzere e che obbliga a prevedere una quota minima di produzioni europee nel catalogo di offerta di “video-on-demand”. Sempre nei servizi, viene criticato l’obbligo di residenza in Svizzera per i manager di filiali svizzere di compagnie assicurative di proprietà estera. - Digitale: attenzione ai flussi di dati
Come menzionato anche dal Vicepresidente americano J.D. Vance nell’ormai celebre discorso tenuto qualche settimana fa a Monaco, anche il settore digitale è oggetto di attenzione. Secondo il motto “gli Stati Uniti innovano, la Cina copia e l’Europa regola”, dove è sottinteso che l’Europa regola troppo (e che la Cina si limiti a copiare non corrisponde più completamente al vero). Il nuovo quadro legislativo svizzero sulla protezione dei dati, in vigore dal 2023, preoccupa le aziende americane, che temono restrizioni nei flussi transfrontalieri di dati. Questo sebbene le nostre normative siano meno severe del GDPR europeo e che recentemente l’esistente Accordo fra Svizzera e Stati Uniti sia stato considerato conforme agli standard di protezione. Da notare che, dopo la levata di scudi contro il succitato discorso di J. D. Vance, qualche giorno fa l’Unione europea, senza tanto clamore, ha preannunciato modifiche sostanziali del GDPR nel senso di un alleggerimento delle regole e una possibile semplificazione del regolamento sull’intelligenza artificiale varato qualche mese fa. Facendo intendere che anche le multe inflitte ai giganti americani del tech nell’ambito della concorrenza potrebbero essere ridotte.
Conclusione
Il rapporto dell’USTR di per sé non punta il dito contro la Svizzera, ma invita a una riflessione costruttiva. Sembra contradditorio rispetto alla mazzata inferta con i dazi, ma in realtà è probabilmente un’altra faccia della stessa medaglia. I dazi quali strumenti di pressione per ottenere (anche) altro. L’obiettivo dichiarato è migliorare l’accesso al mercato e assicurare condizioni di concorrenza eque per tutti.
Per la Svizzera, da sempre Paese aperto e integrato nei circuiti commerciali globali, si tratta di osservazioni che meritano attenzione, anche nell’ottica di rafforzare i legami economici con questo importante partner commerciale mondiale.
Gli stessi americani affermano del resto una chiara volontà di trovare accordi con il nostro paese. “Bastone e carota”, chi riesce a capire come muoversi è bravo, ma forse dovremmo soprattutto esercitarci a leggere meglio fra le righe…